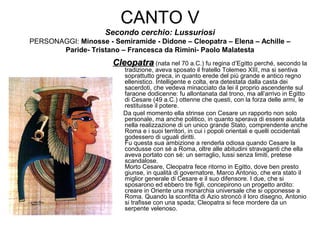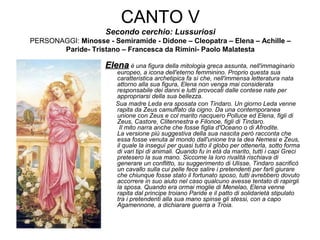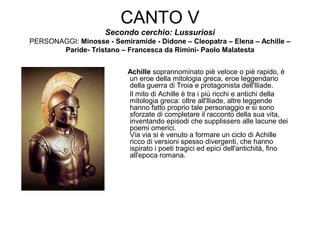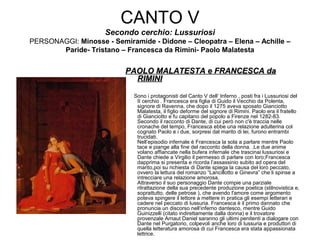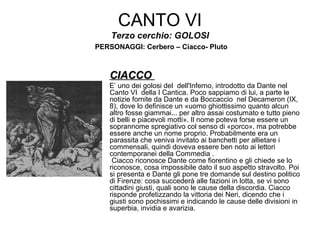Inferno1
- 1. INFERNO:CANTO I La selva;La”Piaggia diserta”;Il Colle Ora:Notte e mattino del 25 marzo(o dell’8 Aprile)1300 PERSONAGGI: VIRGILIO VIRGILIO È il più grande poeta dell'antica Roma (70-19 a.C.), nato da una famiglia di piccoli proprietari terrieri ad Andes (oggi Pietole), nei pressi di Mantova. Ricevette un'accurata educazione grammaticale e si accostò alla filososia epicurea, frequentando una scuola a Napoli. Nel 42 a.C. i triumviri Ottaviano (il futuro imperatore Augusto) e Antonio emanarono un decreto per espropriare alcune terre con cui ricompensare i veterani che avevano combattuto a Filippi contro i cesaricidi Bruto e Cassio, provvedimento che colpì anche Virgilio; riuscì pare a conservare i possedimenti grazie all'intervento di un personaggio potente, forse Asinio Pollione o Ottaviano stesso. Dopo il successo delle Bucoliche, dieci poemetti di tema pastorale pubblicati nel 39 a.C., fu introdotto nella cerchia di Mecenate e aderì al progetto augusteo di restaurazione della pace e della moralità italica, componendo tra 39 e 30 a.C. le Georgiche (poemetto didascalico di argomento agricolo) e dedicandosi poi all'Eneide, il poema epico che narrava la fuga di Enea da Troia e la fondazione da parte dell'eroe della città di Lavinio, nel Lazio. L'opera venne realizzata nel 29-19 a.C. ma non poté essere rifinita in ogni sua parte, in quanto l'autore morì nel 19 a.C. di ritorno da un viaggio in Grecia; nonostante Virgilio avesse raccomandato di bruciarla, gli amici la pubblicarono per volontà di Augusto e l'Eneide divenne il principale poema epico della latinità, consiserata tutt'oggi una delle opere principali della letteratura occidentale. La fama di Virgilio nel Medioevo fu grandissima, diventando ben presto maestro di stile e di poesia e venendo considerato anche un modello di sapienza filosofica, addirittura profeta inconsapevole delle verità cristiane (ciò soprattutto grazie all'EglogaIV, interpretata erroneamente come preannuncio della nascita di Cristo).
- 2. • Virgilio compare nel Canto I dell‘ Inferno, quando soccorre Dante dalle tre fiere nella Selva e da lì lo conduce nel viaggio attraverso due dei tre regni dell'Oltretomba (Inferno e Purgatorio).Il poeta latino è allegoria della ragione naturale dei filosofi pagani, in grado di condurre l'uomo alla felicità terrena e al pieno possesso delle quattro virtù cardinali (prudenza, fortezza, temperanza e giustizia): infatti il Virgilio dantesco guida il discepolo sino al Paradiso terrestre , in cima al monte del Purgatorio, dove il suo posto è preso da Beatrice , allegoria della grazia divina e della teologia rivelata. Secondo Dante ,Virgilio dopo la morte è finito nel Limbo il I cerchio dell'Inferno dove risiedono le anime dei morti non battezzati e degli uomini virtuosi vissuti prima di Cristo. Qui il poeta latino riceve la visita di Beatrice, che lo prega di soccorrere Dante smarritosi nella selva (., , 52-120). Virgilio è definito da Dante suo maestro e modello e ciò è coerente col culto della poesia virgiliana largamente presente nella cultura del Medioevo latino. Oltre a ciò Virgilio aveva fama anche di essere un saggio e sapiente filosofo, il che spiega perché Dante scelga proprio lui come sua guida per i due terzi del viaggio allegorico. Si rivolge quasi sempre a Virgilio con gli appellativi maestro,duca (cioè «guida») e tra i due si crea nel corso delle prime due Cantiche un rapporto assai stretto, non solo di maestro-discepolo ma addirittura di padre-figlio. Ciò è evidente soprattutto quando Virgilio scompare all'apparire di Beatrice ed è definito da Dante , prima che il discepolo scoppi in un pianto dirotto per la sua dipartita.
- 3. CANTO II Fuori dalla Selva;alle pendici del colle. Ora: Sera del 25 Marzo ALLEGORIE: 1) Maria Vergine,la grazia preveniente 2)Lucia,la grazia illuminante 3)Beatrice,”lumen gratiae”,teologia o scienza delle cose divine PERSONAGGI: Virgilio – Beatrice • Beatrice è in realtà Bice, figlia di Folco Portinari, nata a Firenze nel 1266 e che a diciannove anni sposò Simone dei Bardi, morendo ventiquattrenne nel 1290. Nella Vita Nuova Dante racconta di averla conosciuta per la prima volta quando entrambi avevano nove anni e di averla poi rivista a diciotto anni, incontro dal quale era nato il suo amore per lei. Beatrice non è altro che un senhal , ovvero un nome fittizio (secondo la tradizione della lirica provenzale) che significa letteralmente «colei che rende beati». Beatrice è protagonista di molte delle prime poesie stilnoviste di dante poi raccolte nella Vita Nuova e nelle Rime. Nel «libello» giovanile la donna non è solo la donna-angelo dello Stilnovo, ma è già raffigurazione di Cristo e sembra anticipare il valore allegorico che avrà nel poema, ovvero quello della grazia divina e della teologia rivelata che sola può condurre l'uomo alla salvezza eterna e al possesso delle tre virtù teologali (fede, speranza, carità).
- 4. CANTO III ANTINFERNO-IGNAVI Ora: Sera del 25 marzo(o dell’8 Aprile)1300 PERSONAGGI: Celestino V -Caronte CELESTINO V • Pier da Morrone (1210-1296), eremita che il 5 luglio 1294 fu eletto papa col nome di Celestino V dal conclave riunito a Perugia. Dopo qualche esitazione iniziale accettò, venendo poi consacrato vescovo dell'Aquila. In seguito rinunciò alla tiara, soprattutto per le pressioni subìte ad opera del card. Caetani, che gli succedette il 24 dic. 1294 col nome di Bonifacio VIII . Celestino fu da lui rinchiuso nel castello di Fumone, dove morì nel maggio 1296.Dante lo pone con ogni probabilità tra gli ignavi dell’Antinferno, indicandolo come colui/che fece per viltade il gran rifiuto(INF IIIcolui/che fece per viltade il gran rifiuto(INF III, 59-60; non sono mancate altre identificazioni, tra cui Pilato, Esaù, Giuliano l'Apostata). Dante gli rimproverava di aver favorito con la rinuncia alla dignità pontificia l'ascesa al Papato dell'odiato Bonifacio VIII, artefice con le sue trame della vittoria dei Neri a Firenze e dell'esilio politico di Dante.
- 5. CANTO III ANTINFERNO-IGNAVI CARONTECARONTE Personaggio della mitologia classica, figlio dell'Erebo e della notte, traghettatore delle anime dei morti al di là del fiume dell'Ade Acheronte. Virgilio lo descrive nel libro VI dell‘Eneide, durante la discesa agli Inferi di Enea: è un vecchio dall'aspetto squallido, che fa salire sulla sua barca le anime dei defunti ma lascia sulla riva gli insepolti, come Palinuro. Il Caronte virgiliano si oppone al passaggio di Enea, ma la Sibilla che gli fa da guida lo convince mostrandogli il ramo d'oro da offrire a Proserpina , la regina degli Inferi moglie di Plutone. Caronte compare in Inf.III, 82-111, dove Dante si rifà stettamente all'episodio dell' Eneide accentuando i tratti demoniaci del traghettatore e facendone uno strumento della giustizia divina. Inoltre il Caronte dantesco traghetta solo le anime dannate, mentre diverso trattamento è riservato alle anime salve destinate in Purgatorio (esse sono trasportate da un angelo nocchiero che le raccoglie alla foce del Tevere, su un lieve legno che lo stesso Caronte dice dovrà trasportare lo stesso Dante, predicendogli di fatto la salvezza). Il Caronte di Dante è un vecchio coperto di barba bianca, con gli occhi circondati da fiamme, che minaccia severi castighi ai dannati e li fa salire sulla sua barca, battendo col remo le anime che si adagiano sul fondo (forse per stiparne il maggior numero possibile). Anch'egli si oppone al passaggio di Dante, ma è zittito da Virgilio con una formula identica a quella usata poi con Minosse e analoga a quella usata con Pluto . La demonizzazione di Caronte rientra nell'uso tipicamente medievale di reinterpretare in chiave cristiana le divinità pagane, per cui quelle degli Inferi diventavano altrettante figure diaboliche, in qualche caso con notevoli trasformazioni.
- 6. CANTO IV Primo Cerchio o Limbo;Anime Virtuose,ma non battezzate,”Gli spiriti magni” Ora: Sera del 25 marzo(o dell’8 Aprile)1300 PERSONAGGI: Omero – Orazio – Ovidio – Lucano e altre ombre di magnanimi OMEROOMERO È il leggendario autore di Iliade e Odissea , i due massimi poemi epici della letteratura greca. La sua esistenza era ritenuta certa nel Medioevo, benché il testo delle opere a lui attribuite non fosse noto (l'Occidente ignorava il greco); esistevano tuttavia traduzioni latine e rimaneggiamenti tardi, che proponevano varianti di molti episodi, come quello relativo alla morte di Ulisse. Dante lo introduce nel Canto IV dell’Inferno tra gli «spiriti magni » del Limbo accanto ad altri tre poeti (Orazio, Ovidio e Lucano). Lo rappresenta con una spada in mano, simbolo della sua superiorirà sugli altri e anche del fatto che egli era poeta delle armi.Omero è l’unico dei quattro a parlare,rendendo omaggio a Virgilio che torna nel Limbo; Dante è ammesso nella cerchia dei poeti, si trattiene con loro a parlare e li accompagna al nobile castello dove sono mostrati gli altri «spiriti magni».
- 7. CANTO IV Primo Cerchio o Limbo;Anime Virtuose,ma non battezzate,”Gli spiriti magni” Ora: Sera del 25 marzo(o dell’8 Aprile)1300 QUINTO ORAZIO FLACCOQUINTO ORAZIO FLACCO Poeta latino vissuto nell'età di (65-8 a.C.), nacque a Venosa (nell'attuale Basilicata) da un liberto e fu educato a Roma , dove ebbe come maestro Orbilio; frequentò anche la scuola epicurea di Filodemo, in Campania, che influenzò profondamente il suo pensiero e la sua concezione di vita. Recatosi ad Atene per completare gli studi retorici, aderì agli ideali repubblicani e anti-cesariani arruolandosi dopo la morte di Cesare nell'esercito di Bruto, sconfitto nella battaglia di Filippi (42 a.C.). Rientrato in Italia grazie a un'amnistia ma privato del podere di famiglia, fu costretto a lavorare come scriba quaestorius per guadagnarsi da vivere. Conobbe poi l'affermato Virgilio, del quale divenne amico e che lo presentò nel 38 a Mecenate: l'ingresso nel suo Circolo fu la svolta della sua carriera letteraria, permettendo ad Orazio di diventare in breve il principale poeta della Roma augustea Dante lo include tra le anime del Limbo insieme ai poeti Omero,Ovidio e Lucano : i quattro erano considerati nel Medioevo come i principali poeti dell'antichità dopo Virgilio, al di là dei loro effettivi meriti, e l'ordine in cui sono presentati è indicativo probabilmente della gerarchia d'importanza con cui venivano inclusi nel canone (Orazio viene subito dopo Virgilio e Omero). Orazio è definito satiro in riferimento ai Sermones (il titolo latino delle Satire) che è probabilmente l'unica sua opera di cui Dante aveva una certa conoscenza, mentre è assai dubbioso che lo ricordasse come autore anche delle Odi. I quattro si felicitano per il momentaneo ritorno di Virgilio nel Limbo e accolgono nella loro bella scola Dante, che si gloria di “essere sesto tra cotanto senno” ; è assai probabile che essi facciano parte degli «spiriti magni» che albergano nel nobile castello visitato subito dopo, anche se di ciò non vi è cenno esplicito nel poema. Nonostante l'importanza che ad Orazio veniva attribuita nel Medioevo, e che è comunque di gran lunga inferiore al suo contemporaneo Virgilio, scarsi sono i riferimenti alla sua poesia nella Commedia.
- 8. CANTO IV Primo Cerchio o Limbo;Anime Virtuose,ma non battezzate,”Gli spiriti magni” Ora: Sera del 25 marzo(o dell’8 Aprile)1300 OVIDIOOVIDIO Poeta latino vissuto nell'età di Augusto (43 a.C. - 17 d.C.), nacque a Sulmona e giunse giovanissimo a Roma , dove studiò retorica e si dedicò assai presto alla poesia. Entrò in contatto con i principali autori del tempo (Orazio, Messalla Corvino, Properzio) e frequentò la corte dell'imperatore, conducendo vita brillante e contraendo vari matrimoni. Pubblicò un canzoniere di elegie in tre libri, gli Amores, cui seguirono altre poesie di contenuto leggero e galante, come le Heroides(raccolta di epistole in versi con cui le eroine del mito si rivolgono ai loro uomini lontani) e l‘Ars Amatoria, in tre libri, in cui dà consigli agli uomini su come conquistare le donne (nel III libro fa il contrario, forse a parziale scusante dei primi due). Divenne in breve il poeta alla moda della Roma augustea di fine I sec. a.C., grazie ai suoi versi spregiudicati e di argomento erotico; verso il 3 d.C. iniziò la composizione delle sue opere più impegnate, ovvero i Fasti e soprattutto le Metamorfosi , un poema di argomento mitologico in 15 libri che è considerato il suo capolavoro. Nell'8 d.C. fu colpito da un duro provvedimento di Augusto che lo relegava a Tomi, sul Mar Nero, per ragioni che non sono state mai chiarite: il poeta stesso accenna in alcune sue opere a un carmen e ad un error, cioè probabilmente fu allontanato per la sua poesia troppo licenziosa e, forse, per il suo coinvolgimento in uno scandalo a corte riguardante Giulia, figlia dell'imperatore (sul Mar Nero scrisse le Epistulae ex ponto e i Tristia, rimanendovi sino alla morte in quanto neppure il successore di Augusto, Tiberio, revocò il provvedimento). La fama fu assicurata ad Ovidio dalle Metamorfosi, che ebbero uno straordinario successo soprattutto nei secc. XII-XIII e furono oggetto di un intenso lavorio interpretativo in chiave cristiana, cosa comune anche ad altri poeti latini come Virgilio e Stazio (un commento in antico francese intitolato , risalente al XIV sec. e che sottoponeva il poema a questa rilettura allegorica, ebbe un'amplissima diffusione nei decenni seguenti).
- 9. CANTO IV Primo Cerchio o Limbo;Anime Virtuose,ma non battezzate,”Gli spiriti magni” Ora: Sera del 25 marzo(o dell’8 Aprile)1300 LUCANOLUCANO Poeta latino vissuto nell'età di Nerone (39-65 d.C.), nipote del filosofo Lucio Anneo Seneca, nacque come lui a Córdoba in Spagna e fu portato ancora piccolo dai genitori a Roma, dove ebbe la sua prima educazione e mostrò un ingegno precocissimo. Studiò ad Atene e al suo rientro nella capitale fu accolto nella cerchia degli amici dell'imperatore Nerone, del quale Lucano cantò le lodi in occasione delle feste (60 d.C.) ottenendo l'incoronazione poetica. Poco dopo pubblicò i primi tre libri della PharsaliaPharsalia (opera conosciuta anche col titolo BellumBellum civilecivile ), poema epico sulla guerra tra Cesare e Pompeo che divenne una sorta di manifesto politico antimperiale, per cui si consumò la rottura tra lui e Nerone. Nel 62 Lucano entrò a far parte della congiura dei Pisoni e quando nel 65 la trama venne scoperta, Lucano venne arrestato e confessò, accusando tra l'altro anche la madre. Ricevette l'ordine di suicidarsi e si tagliò le vene, declamando un proprio brano poetico. La tragica fine gli impedì di portare a termine il poema, che rimase incompiuto al X libro (è probabile che il numero dovesse essere di dodici, in ossequio alla tradizione dell' rispetto alla quale l'opera presenta comunque molte differenze): i primi sette libri raccontano le vicende della guerra fino alla battaglia di Farsàlo, l'ottavo è sulla fine di Pompeo, gli ultimi due narrano le imprese di in Africa. L'opera è una forte protesta libertaria contro l'assolutismo, presenta uno stile enfatico e declamatorio, contiene varie incongruenze e inesattezze che ne rendono talvolta difficile la lettura; nondimeno, Lucano e il suo poema conobbero grande fama già nell'antichità e durante il Medioevo egli fu considerato tra i principali poeti latini accanto a Virgilio, mentre la sua opera ebbe una vasta trasmissione manoscritta.
- 10. CANTO V Secondo cerchio: Lussuriosi PERSONAGGI: Minosse - Semiramide - Didone – Cleopatra – Elena – Achille – Paride- Tristano – Francesca da Rimini- Paolo Malatesta. SemiramideSemiramide è in parte una figura leggendaria, anche se da molti è stata accostata alla regina babilonese Sammuramat (o Shammuramat), moglie del re assiro. Di lei si disse che era sfrenata e lussuriosa: ne parlano Giustino (martire cristiano del II secolo), Agostino di Ippona e il suo discepolo Paolo Orosio dal quale attinse poi anche Dante Alighieri. Le tradizioni sono diverse: per alcuni fece legittimare l'incesto col proprio figlio, per altri fu scacciata e uccisa dal figlio per sottrarle il potere, per altri ancora finì suicida. Erodoto (V secolo a.C.) e il sacerdote babilonese Berosso (III secolo a.C.) ne parlano come grande sovrana, che durante il suo regno conquistò la Media, l'Egitto e l'Etiopia, e che realizzò grandi opere di pace come l'edificazione delle mura e dei giardini pensili di Babilonia, una delle sette meraviglie del mondo antico.
- 11. CANTO V Secondo cerchio: Lussuriosi PERSONAGGI: Minosse - Semiramide - Didone – Cleopatra – Elena – Achille – Paride- Tristano – Francesca da Rimini- Paolo Malatesta DidoneDidone, o Elissa, è una figura mitologica, regina fenicia fondatrice di Cartagine e precedentemente regina di Tiro. Secondo la narrazione virgiliana si innamorò di Enea quando il figlio di Anchise si rifugiò a Cartagine prima di trovare il Lazio. Disperata per la partenza dell'eroe amato, Didone si uccise con la spada di Enea. Dante nella Divina Commedia colloca Didone nel Canto V dell'Inferno, in compagnia dei celebri Paolo e Francesca, nella schiera degli spiriti lussuriosi. Nel canto Dante non cita per nome Didone, ma la descrive mediante una perifrasi che ne indica i peccati e il nome del marito (L'altra è colei che s'ancise amorosa, /E ruppe fede al cener di Sicheo). Didone, infatti, legandosi a Enea si rese colpevole del tradimento della memoria del marito morto Sicheo, e infine si tolse la vita una volta che Enea l'abbandonò per continuare il viaggio indicatogli dagli dèi.[5] Il topos letterario della donna abbandonata, di cui Didone fa parte, ha viaggiato nella letteratura fino ad Ungaretti in età moderna. Dalla Medea di Euripide e Apollonio Rodio (che ne descrive la giovinezza e l'ingenuità) fino all'Arianna di Catullo del carme LXIV e alla Didone virgiliana e a quella ovidiana della VII epistola, a tutti gli effetti più donna che regina.
- 12. CANTO V Secondo cerchio: Lussuriosi PERSONAGGI: Minosse - Semiramide - Didone – Cleopatra – Elena – Achille – Paride- Tristano – Francesca da Rimini- Paolo Malatesta CleopatraCleopatra (nata nel 70 a.C.) fu regina d’Egitto perché, secondo la tradizione, aveva sposato il fratello Tolemeo XIII, ma si sentiva soprattutto greca, in quanto erede del più grande e antico regno ellenistico. Intelligente e colta, era detestata dalla casta dei sacerdoti, che vedeva minacciato da lei il proprio ascendente sul faraone dodicenne: fu allontanata dal trono, ma all’arrivo in Egitto di Cesare (49 a.C.) ottenne che questi, con la forza delle armi, le restituisse il potere. Da quel momento ella strinse con Cesare un rapporto non solo personale, ma anche politico, in quanto sperava di essere aiutata nella realizzazione di un unico grande Stato, comprendente anche Roma e i suoi territori, in cui i popoli orientali e quelli occidentali godessero di uguali diritti. Fu questa sua ambizione a renderla odiosa quando Cesare la condusse con sé a Roma, oltre alle abitudini stravaganti che ella aveva portato con sé: un serraglio, lussi senza limiti, pretese scandalose. Morto Cesare, Cleopatra fece ritorno in Egitto, dove ben presto giunse, in qualità di governatore, Marco Antonio, che era stato il miglior generale di Cesare e il suo difensore. I due, che si sposarono ed ebbero tre figli, concepirono un progetto ardito: creare in Oriente una monarchia universale che si opponesse a Roma. Quando la sconfitta di Azio stroncò il loro disegno, Antonio si trafisse con una spada; Cleopatra si fece mordere da un serpente velenoso.
- 13. CANTO V Secondo cerchio: Lussuriosi PERSONAGGI: Minosse - Semiramide - Didone – Cleopatra – Elena – Achille – Paride- Tristano – Francesca da Rimini- Paolo Malatesta ElenaElena è una figura della mitologia greca assunta, nell'immaginario europeo, a icona dell'eterno femminino. Proprio questa sua caratteristica archetipica fa sì che, nell'immensa letteratura nata attorno alla sua figura, Elena non venga mai considerata responsabile dei danni e lutti provocati dalle contese nate per appropriarsi della sua bellezza. Sua madre Leda era sposata con Tindaro. Un giorno Leda venne rapita da Zeus camuffato da cigno. Da una contemporanea unione con Zeus e col marito nacquero Polluce ed Elena, figli di Zeus, Castore, Clitennestra e Filonoe, figli di Tindaro. Il mito narra anche che fosse figlia d'Oceano o di Afrodite. La versione più suggestiva della sua nascita però racconta che essa fosse venuta al mondo dall'unione tra la dea Nemesi e Zeus, il quale la inseguì per quasi tutto il globo per ottenerla, sotto forma di vari tipi di animali. Quando fu in età da marito, tutti i capi Greci pretesero la sua mano. Siccome la loro rivalità rischiava di generare un conflitto, su suggerimento di Ulisse, Tindaro sacrificò un cavallo sulla cui pelle fece salire i pretendenti per farli giurare che chiunque fosse stato il fortunato sposo, tutti avrebbero dovuto accorrere in suo aiuto nel caso qualcuno avesse tentato di rapirgli la sposa. Quando era ormai moglie di Menelao, Elena venne rapita dal principe troiano Paride e il patto di solidarietà stipulato tra i pretendenti alla sua mano spinse gli stessi, con a capo Agamennone, a dichiarare guerra a Troia.
- 14. CANTO V Secondo cerchio: Lussuriosi PERSONAGGI: Minosse - Semiramide - Didone – Cleopatra – Elena – Achille – Paride- Tristano – Francesca da Rimini- Paolo Malatesta Achille soprannominato piè veloce o piè rapido, è un eroe della mitologia greca, eroe leggendario della guerra di Troia e protagonista dell'Iliade. Il mito di Achille è tra i più ricchi e antichi della mitologia greca: oltre all'Iliade, altre leggende hanno fatto proprio tale personaggio e si sono sforzate di completare il racconto della sua vita, inventando episodi che supplissero alle lacune dei poemi omerici. Via via si è venuto a formare un ciclo di Achille ricco di versioni spesso divergenti, che hanno ispirato i poeti tragici ed epici dell'antichità, fino all'epoca romana.
- 15. CANTO V Secondo cerchio: Lussuriosi PERSONAGGI: Minosse - Semiramide - Didone – Cleopatra – Elena – Achille – Paride- Tristano – Francesca da Rimini- Paolo Malatesta PAOLO MALATESTA e FRANCESCA daPAOLO MALATESTA e FRANCESCA da RIMINIRIMINI Sono i protagonisti del Canto V dell‘ Inferno , posti fra i Lussuriosi del II cerchio . Francesca era figlia di Guido il Vecchio da Polenta, signore di Ravenna, che dopo il 1275 aveva sposato Gianciotto Malatesta, il figlio deforme del signore di Rimini. Paolo era il fratello di Gianciotto e fu capitano del popolo a Firenze nel 1282-83. Secondo il racconto di Dante, di cui però non c'è traccia nelle cronache del tempo, Francesca ebbe una relazione adulterina col cognato Paolo e i due, sorpresi dal marito di lei, furono entrambi trucidati. Nell’episodio infernale è Francesca la sola a parlare mentre Paolo tace e piange alla fine del racconto della donna. .Le due anime volano affiancate nella bufera infernale che trascinai lussuriosi e Dante chiede a Virgilio il permesso di parlare con loro;Francesca dapprima si presenta e ricorda l’assassinio subito ad opera del marito,poi su richiesta di Dante spiega la causa del loro peccato, ovvero la lettura del romanzo “Lancillotto e Ginevra” che li spinse a intrecciare una relazione amorosa. Attraverso il suo personaggio Dante compie una parziale ritrattazione della sua precedente produzione poetica (stilnovistica e, soprattutto, delle petrose ), che avendo l'amore come argomento poteva spingere il lettore a mettere in pratica gli esempi letterari e cadere nel peccato di lussuria. Francesca è il primo dannato che pronuncia un discorso nell‘inferno dantesco, mentre Guido Guinizzelli (citato indirettamente dalla donna) e il trovatore provenzale Arnaut Daniel saranno gli ultimi penitenti a dialogare con Dante nel Purgatorio, colpevoli anche loro di lussuria e produttori di quella letteratura amorosa di cui Francesca era stata appassionata lettrice.
- 16. CANTO VI Terzo cerchio: GOLOSI PERSONAGGI: Cerbero – Ciacco- Pluto CIACCOCIACCO E’ uno dei golosi del dell'Inferno, introdotto da Dante nel Canto VI della I Cantica. Poco sappiamo di lui, a parte le notizie fornite da Dante e da Boccaccio nel Decameron (IX, 8), dove lo definisce un «uomo ghiottissimo quanto alcun altro fosse giammai... per altro assai costumato e tutto pieno di belli e piacevoli motti». Il nome poteva forse essere un soprannome spregiativo col senso di «porco», ma potrebbe essere anche un nome proprio. Probabilmente era un parassita che veniva invitato ai banchetti per allietare i commensali, quindi doveva essere ben noto ai lettori contemporanei della Commedia . Ciacco riconosce Dante come fiorentino e gli chiede se lo riconosce, cosa impossibile dato il suo aspetto stravolto. Poi si presenta e Dante gli pone tre domande sul destino politico di Firenze: cosa succederà alle fazioni in lotta, se vi sono cittadini giusti, quali sono le cause della discordia. Ciacco risponde profetizzando la vittoria dei Neri, dicendo che i giusti sono pochissimi e indicando le cause delle divisioni in superbia, invidia e avarizia.
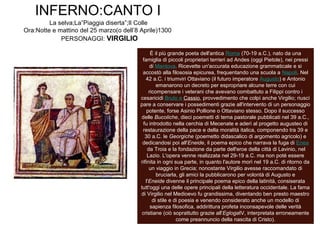
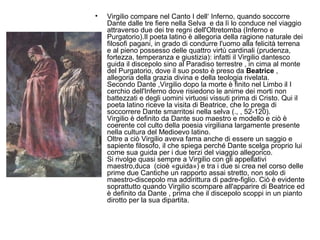
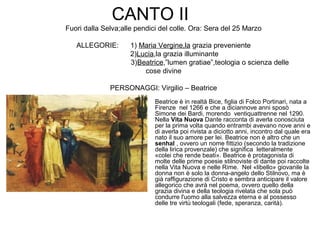
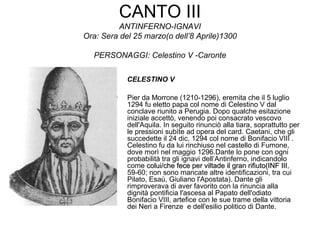
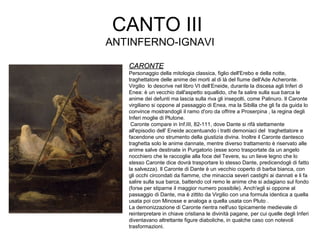
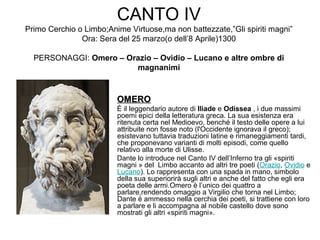
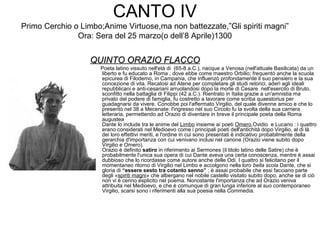
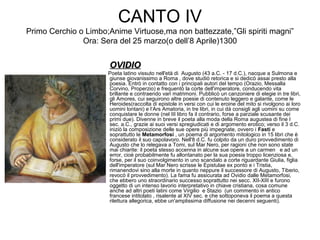
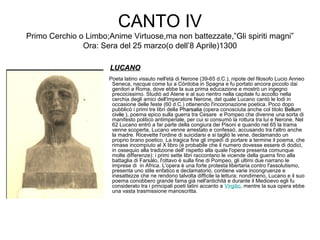
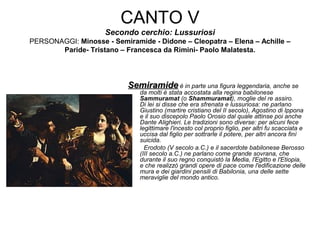
![CANTO V
Secondo cerchio: Lussuriosi
PERSONAGGI: Minosse - Semiramide - Didone – Cleopatra – Elena – Achille –
Paride- Tristano – Francesca da Rimini- Paolo Malatesta
DidoneDidone, o Elissa, è una figura mitologica, regina fenicia fondatrice di Cartagine
e precedentemente regina di Tiro. Secondo la narrazione virgiliana si innamorò
di Enea quando il figlio di Anchise si rifugiò a Cartagine prima di trovare il Lazio.
Disperata per la partenza dell'eroe amato, Didone si uccise con la spada di
Enea.
Dante nella Divina Commedia colloca Didone nel Canto V dell'Inferno, in
compagnia dei celebri Paolo e Francesca, nella schiera degli spiriti lussuriosi. Nel
canto Dante non cita per nome Didone, ma la descrive mediante una perifrasi che
ne indica i peccati e il nome del marito (L'altra è colei che s'ancise amorosa, /E
ruppe fede al cener di Sicheo). Didone, infatti, legandosi a Enea si rese colpevole
del tradimento della memoria del marito morto Sicheo, e infine si tolse la vita una
volta che Enea l'abbandonò per continuare il viaggio indicatogli dagli dèi.[5]
Il topos letterario della donna abbandonata, di cui Didone fa parte, ha viaggiato
nella letteratura fino ad Ungaretti in età moderna. Dalla Medea di Euripide e
Apollonio Rodio (che ne descrive la giovinezza e l'ingenuità) fino all'Arianna di
Catullo del carme LXIV e alla Didone virgiliana e a quella ovidiana della VII
epistola, a tutti gli effetti più donna che regina.](https://image.slidesharecdn.com/inferno1-150219115908-conversion-gate02/85/Inferno1-11-320.jpg)